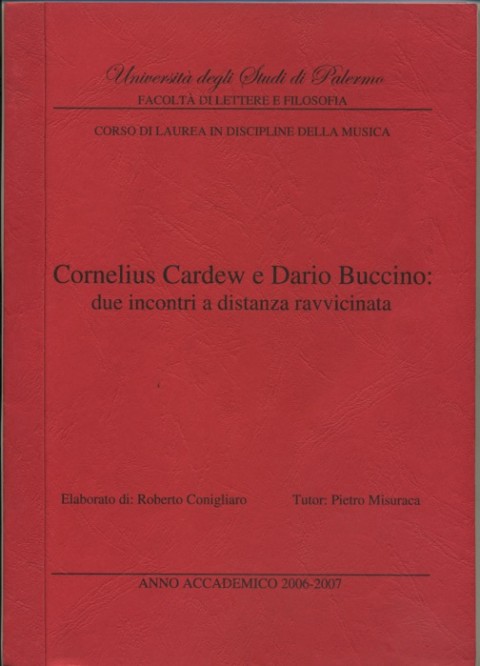Lettera a Roberto Conigliaro
Milano, 3 Settembre 2007
Ciao Roberto!
Rispondo finalmente alla bella domanda che mi hai fatto quasi due mesi fa:
"...Vedo la tua musica come qualcosa di molto intimo, viscerale e mi piacerebbe capire meglio fino a che punto e in quali modi interferisci con l'esecutore e quanta libertà intrepretativa-espressiva ha quest'ultimo nell'eseguire le tue composizioni. Voglio dire: una tua stessa composizione suonata da due interpreti differenti entrambi guidati da te, può suonare in modo nettamente differente oppure grazie al tuo lavoro sull'interprete riesci a controllare in maniera più o meno precisa l'evento sonoro da te ideato?"
La risposta è complessa. Mi piace la tua definizione della mia musica come qualcosa di intimo e viscerale. Non si tratta però solo di un fatto intimamente e visceralmente mio, ma di un tentativo - nuovo e diverso a ogni composizione - di creare una possibilità di espressione intima e viscerale dell'interprete. Dare vita a processi e risultati che siano altrettanto intimamente e visceralmente suoi. Quando non soddisfo entrambe le intimità viscerali, continuo a cercare, finché non ci riesco; sono disposto a lavorare per anni su una stessa composizione e con un dato interprete. Lavoro sempre simultaneamente a più progetti, quindi posso permettermi la frustrazione dell'attesa, perché intanto prima o poi qualche altro figliolo vede la luce. E nei periodi in cui nessun figliolo viene alla luce, continuo pazientemente a lavorare - pur spesso con un'angoscia di fondo molto forte - perché fortunatamente sono incapace di accontentarmi di un risultato che non mi esalti vertiginosamente.
Negli anni ho constatato che se l'interprete e io sentiamo di aver dato corpo a un'espressione intima e viscerale di noi stessi, anche l'ascoltatore vivrà un esperienza d'ascolto intima e viscerale. Ai miei concerti mi è capitato più di una volta di vedere ascoltatori in lacrime, scossi da commozione ed esaltazione. Per me è un grande traguardo. Sostengo, parlando in modo molto grezzo, che se la musica può commuovere ed esaltare, allora è suo compito farlo. Non l'unico compito. Ma un compito nobile, rischiosamente nobile e irrinunciabile.
Questa equazione (espressione iperemotiva mia + espressione iperemotiva dell'inteprete = reazione (iper)emotiva dell'ascoltatore) è un assunto ormai basilare per me, e ha un'implicazione essenziale: lavoro sempre con e sull'interprete. Ogni mia idea non è mai solo un'idea sonora, ma un'idea performativa. Cioè vado alla ricerca di processi corporei interessanti (esperienzialmente e concettualmente interessanti) che diano origine a fatti sonori interessanti (acusticamente, emotivamente, simbolicamente...).
Come ho detto già in altre occasioni, l'insieme di fatto corporeo e fatto sonoro forma quella che chiamo un'idea performativa. L'insieme dato dall'idea performativa e dal suo impatto ascoltuale (impatto su di me - sondabile per introspezione - e impatto sugli altri - sondabile per immedesimazione e non oggettivamente, perché, come è ovvio, accade dentro ciascun ascoltatore) costituisce quella che chiamo un'immagine esperienziale. La costruzione compositiva si fa carico di modulare l'intreccio di immagini esperienziali con l'obiettivo di sovraccaricarne la risonanza simbolica, ovvero la tendenza a scatenare la potenza significatrice, conscia e soprattutto inconscia, dell'ascoltatore. Obiettivo impensabile se è debole la carica simbolica iniziale, quella che comincia a circolare nel contatto tra i due poli principali - la mia immaginazione performativa e l'esperienza corporea dell'interprete in azione.
Tutta la costruzione del mio universo artistico crolla, quindi, se l'interprete non è appagato, esaltato in maniera cocentemente soggettiva da ciò che gli chiedo di fare.
Un certo margine o, meglio, un certo tipo di libertà performativa dell'interprete è perciò una condizione preziosa per il raggiungimento dei miei scopi.
A seconda delle composizioni, o delle diverse parti di una stessa composizione, cerco di capire quale sia il margine e il tipo efficace di libertà da affidare all'interprete. Le mie partiture si fanno carico di organizzare le condizioni corporali essenziali necessarie alla realizzazione di una certa qualità performativa. Ma la pagina - che, a seconda dei casi, può essere ricchissima o poverissima di dettagli... - non nasce per essere autosufficente: è la piattaforma per un lavoro di tipo registico. Attenzione, però, non per questo può essere considerata semplicemente un pre-testo o un promemoria dello svolgimento formale della composizione. E' piuttosto uno strumento che, fin dalle lunghe e laboriose fasi della sua stesura cartacea, indirizza, governa, nutre... anzi, più esattamente, concepisce e struttura il lavoro orale e pratico delle prove.
E' quasi superfluo sottolineare che neanche i sistemi di notazione musicale tradizionali sono autosufficienti, in quanto sono appunto tradizionali. E' la tradizione a dirci come si legge, per esempio, un pentagramma, ed è sempre la tradizione che, almeno in parte, vincola le possibilità d'interpretazione di un codice, che solo apparentemente è oggettivo. La trasgressione più o meno spudorata di tali vincoli può (pur non necessariamente) marcare un'intepretazione più o meno originale o geniale. Qualunque partitura scritta su pentagramma, anche la più dettagliata, costituisce solo una traccia per la realizzazione di un'esecuzione e non combacia con essa. Ma anche volendo, magari per assurdo, minimizzare il peso che le sostanziali sottigliezze agogiche, dinamiche, timbriche, di fraseggio esercitano sulla fisionomia obiettiva di una composizione musicale, la pura partitura non costituirà mai uno strumento autonomo per far rivivere il pensiero del compositore, perché rimane sempre aperta la questione della tecnica strumentale. E', di nuovo, una spessa e vivissima tradizione a dirci come si suona un violino, un pianoforte, una tromba, una chitarra elettrica, un hi-hat... Senza quella tradizione i simboli di una partitura sarebbero lettera morta. Perfino la voce, che ognuno impara a usare fin dai primi minuti di vita, si impara a usare in virtù di una tradizione... Il modo di emettere la voce dei miei amici senegalesi - quando parlano, sospirano, ridono, piangono... - è completamente diverso da quello dei miei amici equadoriani o dal mio. Spostandoci sul piano della musicalità vera e propria, possiamo osservare molto facilmente come la stessa sequenza di note cantata da me o da qualcun altro subisca impressionanti metamorfosi. Provate a intonare una melodia africana, o araba, oppure chiedete a vostra nonna di cantare un pezzo heavy metal. Inoltre, sempre a proposito della notazione pentagrammatica di melodie vocali, è evidente quanto sia ridotto ciò che viene riportato dalla pagina, rispetto alla miriade veramente incalcolabile di sfumature, portamenti, glissati, crescendo, staccati-semiappoggiati-legati... Non parliamo poi di tutti gli altri sistemi di notazione che la nostra e le altrui tradizioni hanno prodotto (un'esempio su tutti, la notazione neumatica del canto gregoriano delle origini) che si incaricano spesso di suggerire dati sensuali considerati, a ragione, significativi, tralasciando però dati oggettivi macroscopici affidati a sistemi teorici e a convenzioni consolidate oralmente ma non per questo ovvie o naturali.
Io sto cercando di plasmare la mia stessa tradizione. Non nel senso che un giorno tutto il mondo potrà eseguire le mie partiture in maniera oggettivamente corretta (sarebbe un'ingenuità - in contraddizione con tutto ciò che c'è di vitale nel Sistema HN - cadere nella banale credenza che possa esistere una tradizione monolitica, sovrasoggettiva, interpretabile univocamente pur nella libertà d'espressione individuale dell'interprete... Una tradizione, cioè, che in mia assenza continui a vivere negli stessi modi in cui prende vita tra le mie mani). No - plasmare la mia stessa tradizione significa formare un modo di lavorare con gli interpreti, un approccio che, negli anni, io possa sviluppare o tradire a mio piacimento, un attitudine tecnica in continua rivoluzione che mi permetta di spingere il risultato musicale in direzioni a me stesso tanto chiare quanto oscure, direzioni coerenti coi miei sogni profondi e, proprio per questo, sempre nuove. Una tradizione che, infine, possa essere raccolta da futuri interpreti, traghettando le mie stesse idee verso sponde per me attualmente inimmaginabili ma amorevolmente filiate dal mio stile operativo. Parlo di tradizione più che di metodo (anche se poi, per quanto mi riguarda, questi son solo gustosi e – perché no – fertili giochi di parole), perché il concetto di metodo sembra più chiuso e impermeabile... Il mio sistema è sistematicamente, strutturalmente permeabile dalla personalità, le esperienze, le risorse, i limiti, le conoscenze, le competenze, il magnetismo, le idee musicali, le intuizioni creative (performative ma in una certa misura anche compositive) di ciascun interprete con cui ho la fortuna di lavorare. Come una tradizione, si forma di bocca in bocca.
Ogni mia partitura, ho detto, è l'organizzazione delle forze performative di un preciso, unico interprete. Per questo non affido quasi mai un pezzo, nato per un certo musicista, ad un altro esecutore. Le volte in cui sono stato costretto a cambiare interprete (o quando, riprendendo in mano col medesimo musicista una partitura di dieci anni prima, ho inevitabilmente trovato l'esecutore - che talvolta sono io stesso - profondamente cambiato) ho dovuto riorganizzare l'apparato parametrico fissato sulla pagina. Talvolta ho dovuto operare evidentissime trasformazioni compositive; comunque ho sempre, immancabilmente, dovuto ripensare radicalmente la funzione e il ruolo svolto dalla partitura nel mio rapporto con l'interprete. Senza contare poi che dopo alcuni anni sono io stesso, come autore ed essere umano, a essere - fortunatamente! - diverso. Cambiano le mie esigenze e le mie pretese nei confronti della musica, e non saprei come allestire una lettura filologica delle mie idee musicali. In particolare essendo concepite nell'ottica HN.
Certo, molte mie composizioni consegnate a un nuovo interprete, rimangono riconoscibili pur attraverso queste radicali metamorfosi della partitura. Ciò che costituisce il volto di un pezzo non sono solo i suoi lineamenti compositivi ma anche, e talvolta soprattutto, le tensioni e le distensioni che, nel qui e ora dell'esecuzione, attraversano i suoi tratti istante dopo istante. Esattamente come accade nel volto umano (quanti figli adottivi, adottando incosapevolmente la capillare maschera comportamentale del viso dei nuovi genitori, finiscono col somigliar loro in senso non solo espressivo ma indiscutibilmente somatico! Per questo i cadaveri non ci sembrano più la persona conosciuta da viva. De-composizione a parte!). Alcuni miei lavori scritti utilizzando il Sistema HN strutturano un'epifania talmente caratterizzata di forze e fatti psicomotorî da risultare individuabili al di là dell'articolazione formale di fatti e forze stesse.
Alcuni miei lavori sono strutturati su elementi oggettivi più eclatanti, e conservano una maggiore riconoscibilità pur se traghettati da un interprete all'altro. Altri lavori invece sono a tal punto innervati e incarnati dalle dinamiche performative, da diventare proprio un'altra cosa se posti nelle mani di un esecutore diverso. A volte rinuncio a rieseguire una composizione se il vecchio interptrete non è più disponibile, o se è cambiato troppo: meglio scrivere un lavoro nuovo! E' più divertente e appassionante. Talvolta, invece, desidero proprio che un pezzo mostri un volto drasticamente diverso a seconda della mano a cui lo affido. Tutto il Sistema HN si basa sulla mobilità di questo equilibrio. Lavoro proprio per far sì che l'irripetibile prenda vita sistematicamente. L'accettazione gioiosa, creativamente reattiva o, quantomeno, coraggiosa dell'instabilità di qualunque risultato è una conquista della vita adulta. Ed è un punto di forza a cui deve affidarsi chi, come me, persegue - tanto nell'arte quanto nell'esistenza - il massimo della vitalità.
In altre parole, lavorando sul medesimo brano con interpreti diversi, preferisco puntare al raggiungimento di un analogo livello di pienezza, spontaneità, visceralità, concentrazione, tensione, slancio, piuttosto che alla realizzazione di un risultato compositivamente simile. Se, per ottenere lo stesso livello di intensità, devo adattarmi alla diversa condotta corporea di un nuovo inteprete, ben venga il mio adattamento. Esempio grossolano: per realizzare un certa qualità di accensione corporea, un dato performer può aver bisogno eseguire le azioni fisiche prescritte contraendo il resto del corpo nella massima immobilità, mentre un'altro può sentire l'esigenza di dimenarsi come un tarantolato. Gli esiti - a livello del microcomportamento esecutivo (e neanche troppo micro!) - possono essere diversissimi. Il mio compito è sorvegliare registicamente la potenza artistica del risultato. Potenza che discuto anche con l'interprete (che è sempre, immancabilmente una persona e un artista che stimo profondamente), riservandomi comunque l'ultima insindacabile (mai definitiva) parola.
L'ideazione di azioni fisiche e sonore che splendano di una bellezza propria al di là (o, meglio, al di qua) della loro organizzazione compositiva, è uno dei punti focali del mio modo di lavorare. La bellezza di azioni concepite in quest'ottica non può ovviamente prescindere da una specifica, ben individuata e definita resa esecutiva. Devo esercitare quindi un controllo serrato su quest'ultima, sulla sua fisionomia esatta e non solo sul grado di intensità con cui si manifesta.
Ho due vie per raggiungere il mio scopo.
1 - Parametrizzare l'atto corporeo in modo da creare condizioni fisiche che necessariamente inducano l'interprete a eseguire quell'azione in un determinato modo, o in modo che alcuni aspetti dell'azione siano segnati da un'imprevedibilità fortemente caratterizzante (apnee, contrazioni muscolari, parametri concettuali tipo "paziente / molto paziente / più paziente possibile", interferenze corporali, etc...).
2 - Spiegare, mostrare, condurre, ma spesso anche discutere, negoziare con l'interprete - in sede di prove, ricerca esecutiva, training performativo - il risultato esecutivo a cui aspiro che si arrivi.
La mia idea in merito al risultato da ottenere impone una determinata direzione al lavoro che svolgo con l'interprete, ma di certo non mi interessa forzarlo in direzioni verso le quale non lo scopro già inclinato. Sarebbe un lavoro mortificante per lui, noiosissimo per me, e comunque inutile perché il risultato porterebbe su di sé le avvilenti tracce dell'inautenticità. Questo non vuol dire, però, che io assecondi tutti i capricci dell'interprete o che non vada a scuotere il suo bagaglio di capacità esecutive consolidate e il suo repertorio di gustosi tic comportamentali. Tutt'altro. Spesso spingo il performer contro se stesso (cercando sempre, ovviamente, di fermarmi prima di perdere definitivamente la sua fiducia!) proprio per indagare il tesissimo campo di forze che viene a formarsi tra le sue abilità consolidate e i miei stupri. Stupri dosatissimi, a subire i quali si deve comunque necessariamente avere una certa vocazione [1].
Alla luce di quanto detto finora, diventano evidenti i motivi per cui non lavoro quasi mai in astratto, senza cioè plasmare la partitura su un certo preciso interprete in carne e ossa, un individuo con il quale abbia, o almeno abbia avuto, un contatto musicale e umano diretto. L'ho fatto con Il fondo a cui richiamare il moto del pettine, composizione per flicorno e violoncello, e infatti ho iniziato il pezzo tredici anni fa e non l'ho ancora finito! Avevo cominciato a comporlo per Daniele Moretto e Marcella Schiavelli. Non ricordo esattamente come mai la collaborazione con Marcella si sia interrotta, (questioni pratiche, non artistiche) ricordo bene invece che, a un certo momento, l'allora giovanissimo e già bravissimo Daniele diventò il trombettista degli 883 e si lanciò in una divertente e remunerativa carriera commerciale che gli ha impedì - quantomeno psicologicamente - di continuare a coltivare un progetto di schietta ricerca come quello avviato con me (lavorando gratis! Almeno fino al momento delle agognate esibizioni concertistiche).
Ma il progetto aveva ormai acquisito una sua identità fetale profonda e ha continuato a bussarmi dentro, chiedendo di vedere la luce. Mi sono fatto prestare una tromba, ho acquistato un dignitosissimo violoncello di fabbrica e ho cominciato a lavorare non solo per comprenderli fisicamente, attraverso il mio corpo (cosa che faccio con qualunque strumento per il quale compongo) ma per padroneggiarli davvero, cercando di definire prassi corporee tanto forti quanto "neutre", cosicché chiunque se ne sarebbe poi potuto appropriare. L'handicap principale di tale modo di lavorare, però, non era tanto nel rischio di definire tecniche esecutive destinate a restare puri fatti miei (avrei pur sempre potuto diventare esecutore della parte per violoncello), quanto nel fatto che, lavorando con questa spada di damocle sospesa sul capo, tutto il lavoro restava come sospeso, e non riuscivo a trovare una forma compositiva convincente. Mi sembrava sempre un pezzo inessenziale e periferico rispetto alla mia pressione interna, nonostante dentro di me echeggiasse ancora, essenziale, necessario e centrale, il tonfo dell sua intuizione primigenia.
Anni dopo ho trovato due interpreti perfetti in Cristina Abati e Mirio Cosottini e, nel giro di una notte, il pezzo stesso mi ha dettato le direttive fondamentali per la sua definizione esecutiva e - consustanzialmente - compositiva. Nell'arco di poche settimane ho realizzato la prima stesura di quella che sarà la versione finale, e in questi mesi (compatibilmente con le solite infinite e massacranti difficoltà organizzative legate alle possibilità, ancora troppo rare, di immolare in concerto le mie composizioni) sto lavorando con i due interpreti per filtrare le idee, indirizzarle, finalizzarle, concretizzalre e metterle alla prova della loro azione e del mio ascolto.
Mirio Cosottini è stato successivamente sostituito da Sergio Montemagno, musicista straordinario con un passato da atleta, padrone della propria fisicità (respirazione e performance muscolare) con la potenza che solo uno sportivo può avere e la libertà immaginifica che (lo dico provocatoriamente) solo un ex-sportivo può raggiungere.
Non saprei decidere quanto il termine interpretazione sia appropriato per definire il ruolo creativo dell'interprete nei miei lavori. Tralascerei qui, però, ogni considerazione e riflessione semantica e semiotica (noiosa e sdrucciolevole) sull'argomento. E per confondere ancora più le acque sottolineo il fatto che spesso discuto con l'interprete, in un vero e proprio lavoro d'equipe, le stesse scelte compositive. La percezione che l'interprete ha del proprio stesso agire è una sonda importante calata dentro le implicazioni nascoste, per non dire addirittura inconsce, delle mie stesse idee musicali-performative, sonda indispensabile per comprendere come esporre tali implicazioni alla giusta luce o celarle nella giusta ombra.
Comporre per me è - come suonare - un'attività relazionale. Non parlo di "comunicazione", perché è un termine inflazionato, ormai disgustoso e spesso, per me, incomprensibile. Parlo di relazione. Compongo per entrare in relazione con gli altri (interpreti, ascoltatori, studiosi...) in modo tale da ricavarne la spinta - sufficientemente corroborata affetivamente - per entrare in contatto con parti di me delle quali ho perenne, tragica nostalgia, parti che riesco a far emergere nel cerchio della mia esperienzialità consapevole solo attraverso la presenza reale o interiore di un'altra persona. Esattamente come accade con l'eccitazione sessuale, la tenerezza, la commozione o certe forme di pazienza, di allegria...
Il lavoro corporeo non è un fine in sé (non mi interessa certamente solo la musica "molto fisica"...!), è semplicemente la via che mi è più congeniale. Perseguendo il massimo coinvolgimento emotivo di tutti i soggetti implicati nel fatto musicale (autore, inteprete, ascoltatore), considero inevitabile l'immersione nel mistero della fisicità, poiché non è concepibile un'emozione priva di una propria manifestazione somatica, fosse anche la più sottile e occulta. Ovviamente non sono solo le reazioni emotive smaccatamente fisiche a interessarmi, anzi, sono proprio i traumi invisibili e sotterranei (traumi preziosi, che un fatto artistico animicamente e spiritualmente carico può incidere) ciò che perseguo più tenacemente, attraverso il lavoro, la riflessione, la sperimentazione, l'attesa, la verifica più paziente. Ritengo però che, affinché un terremoto sordo, profondo, dalle conseguenze fertili, si verifichi nell'universo interiore dell'ascoltatore, sia necessario tendergli una trappola ipnotica che, inchiodando la sua attenzione a una forte pressione sensuale ed emotiva, lo renda spugnoso ai miei propositi, sospendendo o semplicemente aggirando la sua vigilanza raziocinante, spiegazionista e letteralizzante [2].
Il corpo, come il pensiero puro (perché il corpo vivo ovviamente è fatto di pensiero), dietro la pressione di esigenze affettive ed emotive, è capace di potentissime intuizioni e iniziative estemporanee. Gli atti del corpo possono lasciar immediatamente una traccia formata, compiuta (non nel senso di conchiusa, ma nel senso di effettuata, realizzata, fatta), mentre gli atti di puro pensiero sono costretti a una continua dispersione; è tanto ciò che del pensiero viene perso in ogni istante senza lasciare traccia [3]. Una dispersione, beninteso, che non necessariamente costituisce la debolezza del pensiero, perché lo costringe a tornare continuamente sui propri passi e distillare la sostanza essenziale del proprio turbinio: l'Idea.
Idea - punto di forza anche degli atti corporei: un processo corporeo innervato da un'idea essenziale di sé stesso, sostenuto da una lucida concezione esperienziale, acquista forza paradigmatica e, anche in virtù di questa, conquista libertà di manovra estemporanea, perfino libertà di tradimento di sé. In una parola: complessità.
Tale è la complessità di una interpretazione musicale profonda, in cui sia coinvolto tutto il corpo e non solo la periferia impegnata direttamente nella produzione del suono (è questo coinvolgimento contro-periferico l'obiettivo metodologico centrale del Sistema HN), che trattenere nella memoria tutti i dettagli e le sfumature di un'interpretazione è quasi impossibile. Quasi impossibile è già mentalizzarli, percepirli coscientemente durante l'ascolto, ma riviverli con esattezza nell'immaginazione è un'impresa forse sovrumana. E' più facile, forse, ricordare nel dettaglio una composizione che un'interpretazione.
Tutti i sistemi musicali tradizionali hanno cercato di catturare la potenza di questa complessità. Il nostro contrappunto, per esempio, è frutto della sedimentazione di prassi corporee, di gestualità melodiche cristallizzate ma nate in misura determinante nel vivo del fare musica... Che bello allora tentare, oggi, una via alla composizione dove il dettaglio compositivo sia generato dagli impulsi profondi del corpo, da una sapienza musicale sepolta nelle carni, nel sistema nervoso, nell'apparato muscolare... Nelle zone profonde del cervello, quindi. Pensiero somatico.
D'altronde non saprei procedere diversamente. Sono mio malgrado un iper-fisico (e un iper-emotivo). Amo la musica effettivamente "suonata" da corpi in azione, pur amando molti pezzi di musica elettronica. E se un suono che vado disegnando nella mia immaginazione, va poi impugnato fisicamente da parte di un esecutore, allora preferisco indirizzare la mia immaginazione direttamente verso l'interprete, elaborando tattiche per impugnare lui. Nei primi anni novanta ho a un certo punto constatato che, nonostante tutti i miei sforzi di invenzione sonora "pura", la mia immaginazione procedeva immancabilmente tratteggiando fatti performativi. Questa scoperta non mi stupì troppo, data la mia passione di sempre per l'improvvisazione, oltre che per la composizione. E, così come mi annoierei a dedicarmi sistematicamente all'improvvisazione "pura" (che mi costringerebbe a tacitare in misura insopportabile e soffocante la mia fame di organizzazione, speculazione, formalizzazione, definitivizzazione e il mio desiderio compulsivo di perseguire la ripetibilità di ogni esperienza vitale), mi annoierei mortalmente a dedicarmi sistematicamente alla composizione "pura", rinunciando alla mia fame di sensualità diretta e ingombrante, di estemporaneità, di istintività dionisiaca, di perdita di controllo, di contatto con gli altri musicisti, di eccitazione performativa scatenata sul limite della trance e mortificando la mia esigenza languida e febbrile di irripetibilità di ogni esperienza vitale.
Negli ultimi anni lavoro molto anche su me stesso come interprete. Questo facilita alcuni procedimenti ma ne complica altri. E' difficile stimolare se stessi, scuotersi e suscitare la propria stessa curiosità, inseguire - con la metodicità propria della ricerca compositiva - la propria visceralità - che, per sua stessa natura, è un torrente di processi tendenzialmente incontrollati.
Cioè, più che difficile è spaventoso. So benissimo come provocare in me stesso una reazione viscerale, ma è difficile superare le mie stesse resistenze a farlo davvero. Se lavoro su un altro, posso provocarlo poco alla volta e osservare le sue reazioni, per mantenerlo su quel filo sospeso tra shock e sicurezza che - complice il grande clima di fiducia recirpoca che, come dicevo prima, cerco di creare - gli permetta di dare il meglio di sé, senza rimanere paralizzato dalla paura. Trovare questo equilibrio in me stesso è più facile e più difficile al tempo stesso. Di sicuro è interessantissimo, non solo artisticamente ma anche esistenzialmente.
La lamiera d'acciaio (e soprattutto l'apparato di tecniche esecutive che negli anni ho messo a punto per farne suono) si è rivelata uno strumento particolarmente efficace per organizzare e spingere le metamorfosi profonde che desidero fortemente affrontare. Sento che ha ancora molti doni da farmi, sento che molte pressioni sepolte - che cercano ancora esistenza in me - e molte tensioni - che cercano senso e contentezza - possono trovare Vita attraverso il lavoro compositivo, speculativo e concertistico con i fogli metallici...
Probabilmente lo scopo compulsivo delle mie pratiche creative, scopo in (minima) parte inconfessato anche a me stesso, è quello - utopico e regressivo - di potermi guadagnare accesso libero e impunito a stati dionisiaci di eccitazione e di trance ipnotica. Esaltazione e quiete, stati in cui la mentalizzazione dell'esperienza sia pressoché del tutto sospesa o comunque scorra a margine, indifferente e inascoltata, come in uno stato di ebbrezza da alcool o droghe... Ho potuto sperimentare così poco e così superficialmente gli effetti delle droghe di qualunque tipo sul mio corpo e il mio cervello, da non osare neanche nominarle come termini di paragone. Sono costretto a cercare per altre vie quegli stati di possessione e di stordimento della vigilanza cognitiva per i quali sento una nostalgia struggente, nostalgia per il ritorno nel grembo regressivo (privo di obiettivi differiti e di responsabilità...) di uno stato di abbandono infantile a forze, gioie e spaventi più grandi di me. Un progetto esistenziale involontario e pericoloso, che sento l'imperativa necessità di impugnare e cavalcare più consapevolmente possibile e di non reprimere. Remprimerlo sarebbe il vero pericolo: ho constatato infinite volte, nella mia ormai non più giovanissima esistenza, quanto sia demoniaca e insopprimibile la sua forza. Tentare di soffocarla significa provocarne l'imbestialimento e portarla all'esplosione. Tante volte sono esploso, e un po' esplodo tutti i giorni.
Rimane l'altra strada. Scendere in verticale dentro l'occhio oscuro del ciclone, dove le forze convergono e da cui divergono. Calarmi nella centrale profonda dove sono nascoste le leve della disinibizione. Dove lo scatenamento massimo della tempesta coincide col massimo della quiete. Precipitare abissale, e allo stesso tempo levitare verso le zone aeree del controllo nitido e leggero di sé.
Dovrebbe essere chiaro a questo punto il complesso intreccio di libertà e fedeltà (corporea, concettuale ed emotiva) che lega i miei interpreti alle mie partiture, e me ai miei interpreti e alle mie stesse azioni musicali. Senza libertà o senza fedeltà, così come senza radicale coinvolgimento fisico, sentimentale, intellettuale, non ci sarebbe nessuna discesa dionisiaca e nessuna sublimazione apollinea. Nessuna possessione. Meglio di così non so dire.
Il lavoro su di me stesso, ovviamente, non avviene solo nel momento in cui suono, nel momento cioè del contatto corporale-performativo con le idee compositive, ma ha luogo in egual misura nel momento in cui compongo, nel momento dell'invenzione, della messa a punto e della distillazione formale delle idee. Definiamolo il momento della performance concettuale [4], procedura dotata di una propria innegabile - lo affermo con la massima umiltà - discendenza dalle procedure sapienziali alchemiche. Vorrei illustrare quest'ultima affermazione con un adeguato torrente - ordinato, corente e paradossale - di parole ma la questione è troppo fluida per essere descritta verbalmente; non è ancora arrivato per me il momento di descrivere analiticamente i processi autoconoscitivi che strutturano la mia prassi combinatorio-compositiva e ne vengono a loro volta strutturati (né forse quel momento arriverà mai). Mi manca la necessaria distanza da un flusso di atti mentali, scelte, intuizioni, dissoluzioni e coagulazioni ideative che costituisce la fibra profonda - ora sommersa, ora manifesta - della mia vita quotidiana. I quaderni su cui scrivo i miei appunti, comunque, sono numerati e archiviati (così come è il più possibile lineare e coerente la stessa numerazione delle composizioni), non solo per non smarrirmi nel mio stesso lavoro ma anche per permettere ad altri la fruizione di questo livello speculativo.
Performance compositiva, performance esecutiva. Performance ascoltuale, performance speculativa. Processi miei, dell'interprete, dell'ascoltatore... Questa con-fusione di ruoli spiega ancora una volta perché per me "controllare" un processo e il suo esito non significa realizzare un processo che ripetuto porti allo stesso quasi identico risultato! Quello che mi sta a cuore è il processo di coinvolgimento: causare relazione, infezione tra me, gli altri, la partitura (quindi, come ho già detto, relazione - non meramente esecuzione o interpretazione). Per questo cerco di non tirarmi indietro (salvo che per stanchezza!) dal parlare, anche tecnicamente (con la necessaria essenzialità ed efficacia comunicativa), delle mie idee musicali e artistiche con chiunque e in qualunque situazione (in treno, al pub, a letto...). Non avrebbe senso. La mia relazione con gli altri (relazione biunivoca, perché ascolto attentamente ogni reazione o opinione che suscito) esiste non solo nel momento del concerto o delle prove. Sarebbe una tristezza. E - a pensarci bene - sarebbe la prima volta nella storia del pensiero artistico che si verifica un tale isolamento ermetico. Questa emmorragia di significati, questo contagio di significazioni non sono un'invenzione della post-modernità, come banalmente siamo portati a credere. La più soggettiva e personale delle ricerche artistiche, risponde sempre - e da sempre - a una chiamata collettiva o, quantomeno, sovraindividuale.
Col trascorrere della vita si impongono esigenze interiori sempre nuove. Attraverso il lavoro artistico cerco di portare alla luce e incarnare in modo pieno parti di me, tendenze emotive, risorse spirituali, vocazioni represse, desideri mutilati, inclinazioni mortificate che, fino a pochi anni prima, magari ho sopportato di trascurare e che, a un certo momento dell'esistenza, cominciano a fare un gran casino dentro di me pur di tentare disperatamente di vivere la propria fase di pienezza e coraggio.
Il livello di dolore che perseguita la mia vita è piuttosto alto (come quello che perseguita la vita di chiunque, suppongo), il lavorio creativo avrà sempre nuovi naufraghi sepolti nel mio corpo interiore da correre a rifocillare e, possibilmente, restituire al mondo o almeno a una navigazione sopportabile. Questa condanna a scavare e scovare sempre nuovi strati di drammi inconsolati è salvezza per me come artista, perché mi inchioda a una pratica Creativa segnata da autentica Necessità, ma è tragedia per me come uomo. Tragedia pesante... Certo, sono in buona compagnia - l'intero genere umano! E' già un sollievo che io abbia la coazione a lasciare, del lavoro su me stesso, traccia artistica. Secrezione piacevole e nutriente. Come molte secrezioni. Dio, che schifo di immagine. Ci siamo capiti, comunque, non era solo una battuta. Secernere è bello. Far secernere pure. Secernere e far secernere simultaneamente è il compimento dell'amore carnale. Mica poco. L'arte non può nulla più dell'amore. Ma neanche tanto meno. Poi ognuno decida, secondo la propria cosmogonia morale, religiosa, culturale e metafisica la funzione, il senso, la necessità di Arte e Amore.
Il minimo che si possa dire di entrambi è che sono meglio del puro dolore.
Questo credo.
Note
[1] Non è il caso (per esempio) di Francesco Dillon, violoncellista, al quale sono legato da amicizia e stima il quale, dopo un primo momento di curiosità, si è dichiarato del tutto indisponibile a lavorare con me, a farsi scuotere e toccare (per dirla con le sue stesse parole) in zone così profonde come quelle da cui sgorgano i suoi comportamenti performativi e corporei...
[2] In fondo si tratta di musica... Scienza degli affetti, si diceva pochi secoli fa, con un termine che oggi, al nostro orecchio, suona dolcemente ambiguo: scienza dei sentimenti affettuosi o scienza delle impressioni? Sicuramente costruzione sensuale ed emotiva. Asserzione questa che perfino il nostro secolo non ha mai potuto confutare. Il 900 migliore - al di là delle dichiarazioni programmatiche di alcuni dei suoi protagonisti - non ha tentato di negare la natura sensuale della musica e, tutto sommato, neanche quella emotiva. Neppure la musica contemporanea più speculativa lo ha fatto. Ha semmai contrapposto una costruzione sensuale ed emotiva asciutta, paradossale, potente, polemica, alle pose sensuali ed emotive logore, decadenti, coformiste, regressive, designificate in cui rischiava di impantanarsi la nostra cultura a cavallo tra '800 e '900. La produzione migliore di Stockhausen, Xenakis, Boulez, Cage, Scelsi, Ligeti, Nono, Bussotti, Feldman, Berio, ha questa forza smagliante di opposizione. Nei casi, numerosissimi, in cui questa forza viene persa, le avanguardie si infognano in una grottesca fiacca riproposizione di movenze finto anomale ma in realtà over-collaudate, oppure (nel delirio - energicamente denunciato da Adorno prima e da Metzger poi - di un accademismo della modernità) in un'ossessione misuratrice, sezionatrice e neutralizzatrice di ogni impulso musicale profondo. Ossessione che è la più triste negazione di ogni tenero, entusiasta, malinconico slancio erotico e affettivo... Non voglio certo affermare qui che il pensiero analitico sia nemico dell'affettività. Anzi, ritengo che possa e debba esserne un grande alleato. Ma non deve cedere alla tentazione rassicurante di sovrapporsi ad essa fino ad avvilirla.
[3] Cfr. George Steiner - Dieci (possibili) ragioni della tristezza del pensiero (Garzanti)
"E' quasi incredibile quanto sia dispendioso il pensiero. Consumo ostentatorio al suo peggio. Ricerche neurofisiologiche hanno provato a localizzare e valutare numericamente le "onde cerebrali" emesse dalla corteccia. Hanno cercato di identificare i quanta di energia [...].
Il punto è questo: i processi di pensiero, siano essi consci o inconsci, il flusso del pensiero dentro di noi, tacito o articolato, nella veglia o nel sonno - quei rapidi movimento oculari tanto studiati negli ultimi decenni - sono, nella stragrande maggioranza dei casi, confusi, senza scopo, dispersi, sparpagliati e inspiegati. Sono, letteralmente, "dappertutto" [...].
La loro economia è di uno spreco e di un deficit quasi mostruoso. Forse non esiste attività umana più stravagante."
(pagg 43-44)
[4] Cfr. George Steiner - Dieci (possibili) ragioni della tristezza del pensiero (Garzanti)
"Secondo la famosa osservazione di Alexander Pope, è la forma verbale, non il contenuto, che dà un'impressione di novità. Il linguaggio e i diversi codici simbolici possono in effetti articolare un pensiero, un'immagine concettuale con una forza, una completezza o un'economia senza precedenti. Lo shock performativo può essere intenso."
(pag 32)
Copyright © 2007 Dario Buccino